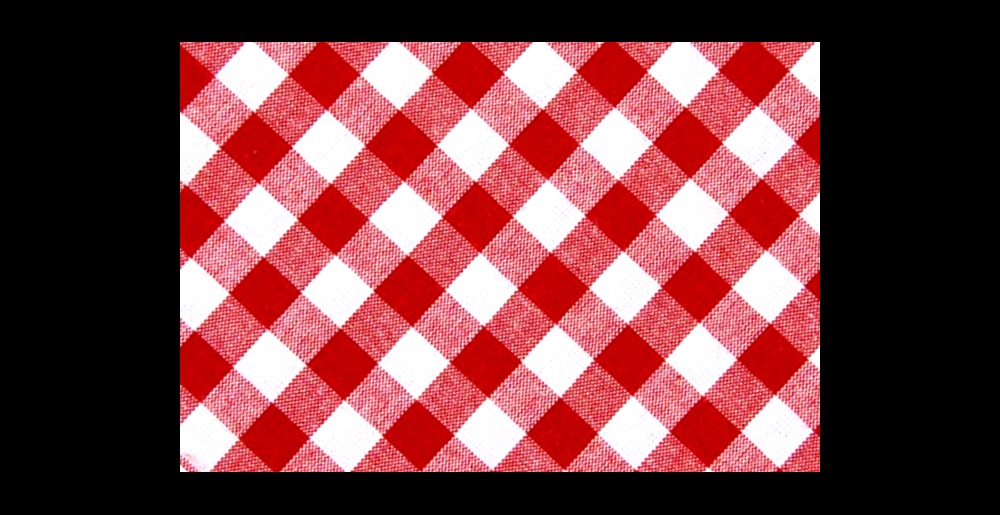Tommaso Melilli a 18 anni fugge da Cremona, dall’idea di provincia, e vola in Francia per studiare letteratura. Qualcosa però va storto:
sono andato a vivere a Parigi, e ci sono arrivato immaginando di fare le cose che – di solito – fanno tutti quelli che vanno a vivere a Parigi da ragazzi: leggere tanti libri complicati, incontrare altre persone che leggono libri complicati e passare il resto delle notti della mia vita seduto ai tavolini dei bistrot a parlare con quelle persone, non guadagnare quasi nulla e, accidentalmente, salvare il mondo. Le cose non sono andate proprio come avevo previsto: ho effettivamente studiato letteratura e affini per qualche anno, in un’università di periferia, dove ho imparato tante cose, ma dove non ho incontrato quelle altre persone che cercavo disperatamente. Ho scoperto che i bistrot chiudono presto la sera, che il vino costa troppo e che gli altri hanno sempre meno voglia di fare amicizia con gli sconosciuti, e quindi con me. Le persone giuste per me però alla fine le ho trovate, e le ho trovate proprio nei bistrot. Ci è voluto un po’ a capirlo, perché non erano sedute ai tavolini: erano dietro il bancone e in cucina. Da un giorno all’altro mi sono ritrovato a fare il cuoco.

Oggi Melilli ha 30 anni, è un cuoco affermato e scrive per Rivista Studio (per cui ha curato la rubrica Tovagliette) e per l’edizione francese di Slate. Il suo percorso umano e professionale è speculare e opposto al mio: ho frequentato la scuola alberghiera, ho lavorato (e lavoro) in bar e cucine, poi mi sono messo a studiare letteratura. Non ho potuto evitare, dunque, di leggere il suo I conti con l’oste. Ritorno al paese delle tovaglie a quadretti (Einaudi 2020) alla luce della mia formazione e delle mie esperienze, né di concepire quest’intervista come un surrogato delle chiacchiere che i ristoratori si scambiano nel day off.
Questo perché I conti con l’oste non è un libro di cucina, bensì di cucine, di persone che ci vivono dentro e della loro vita incomprensibile agli occhi di chi non è avvezzo al mestiere. Melilli si stanzia provvisoriamente come guest chef in vari locali e in varie parti d’Italia (Roma, Milano, Torino, Cremona, la Val Varaita) e utilizza questi lassi di tempo per portare alla luce i pensieri di chi, quando andate a cena fuori, vi dà da mangiare, vi accoglie e vi fa stare bene. Il suo è sì un viaggio a ritroso verso il paese delle tovaglie a quadretti, l’Italia delle trattorie, delle osterie, dei locali dove si mangia bene ma-mia-mamma-lo-faceva-meglio, ma il fulcro del testo non è tanto lo spostamento geografico in sé e per sé quanto proprio la staticità, il ruolo della cucina come centro di gravità permanente attorno al quale orbitano i giorni del mestierante, la filosofia della ristorazione.
Ospite nella cucina del Portico di Paolo Lopriore, Melilli nota come la “cosa veramente sconvolgente” sia il fatto che lo chef “non impiatta: concepisce un piatto, o per meglio dire una ‘portata’, che è fatta di un elemento principale […] e poi lo accompagna con vari contorni, varie salse e vari condimenti” che “vengono serviti al tavolo separatamente, ciascuno in una teglia o in una ciotola separata, con un cucchiaio che permette di prendere quanto se ne vuole. I piatti che stanno davanti ogni commensale sono vuoti: ti devi arrangiare da solo, e decidere tu le quantità e le modalità d’interazione fra i diversi ingredienti”. In un certo senso, I conti con l’oste può essere considerato un po’ come una portata di Lopriore: hai ordinato un piatto e ti arriva smontato, e spetta a te scegliere se prendere le atmosfere dei locali, le vite di chi sta in cucina oppure, come ho fatto io, gli aspetti pratici e teorici della ristorazione.
Cominciamo dall’inizio. Sei partito per la Francia molto giovane, a 18 anni, per andare a studiare letteratura. Oltre al gesto che reputo molto coraggioso, era così forte il desiderio di fuggire dalla provincia?
A me non è mai sembrato poi così coraggioso partire, non l’ho vissuta così. Per come sono fatto io ci sarebbe voluto molto più coraggio a rimanere lì. Non ce l’avevo e non ce l’ho tutt’ora, quel coraggio.
Com’è stato il tuo inserimento all’interno del mondo della cucina e com’è proseguito il tuo percorso accademico?
Il mio primo lavoro in cucina è stato in un ristorante con un tavolo solo. Era abbastanza facile dal punto di vista tecnico, però dovevo raccontare quello che stavo facendo a 5-6 sconosciuti mentre lo facevo. Ho imparato a fare due cose contemporaneamente: cucinare e raccontare, e credo di non aver mai smesso. Il mio percorso accademico non è proseguito in alcun modo.
Se qualcuno mi chiedesse di cosa parla il tuo libro, risponderei che non parla di cucina, ma di cucine, di ristoranti, trattorie, osterie, e soprattutto delle persone che le animano. Sei d’accordo?
Sì, certo. Di libri che spiegano come si cucinano le cose ce ne sono tanti, spesso fatti coi piedi. Volevo scrivere un libro che raccontasse come nasce quell’alchimia che ci fa star bene quando mettiamo “le gambe sotto il tavolo” di un posto.
‘Andare in merda’. Trovare la nota a piè di pagina per spiegare che, nonostante le sonorità volgari, si tratta di un tecnicismo, mi ha emozionato. Anche far capire la differenza che corre tra preparare un piatto a casa e al ristorante. Secondo la tua esperienza, quanto è distante dalla realtà la percezione del lavoro nella ristorazione in chi non ha idea di come funzioni una realtà del genere?
Chi non ha mai lavorato in cucina non ne ha la minima idea. Sono molto contento che in questa stagione di Masterchef, finalmente, abbiano mostrato la differenza fra mise en place e servizio. Da questo punto di vista ho sentito il bisogno viscerale di scriverlo proprio perché sono stufo di raccontarlo a voce, lo faccio da otto anni.
“La cosa che quasi tutti chiamano tradizione in realtà vuol dire pigrizia, abitudine, e a volte anche insicurezza. […] Scusatemi, ma la tradizione non esiste: c’è solo la ricerca”. Quante persone potrebbero sentirsi offese da queste frasi?
Pazienza, c’è sempre qualcuno che si offende per qualcosa ormai. Ma un conto è offendersi per qualcosa di violento che tocca una parte intima di noi, e quello va evitato. Un’altra cosa è offendersi perché una frase va a toccare una delle tante storie che ci raccontiamo per comodità: se anche solo il 5% di chi si offende poi cambia idea valeva la pena di farlo.
All’interno del libro dici che le persone vanno a mangiare fuori ma poi commentano che avrebbero mangiato meglio a casa propria. Vorrei agganciare una considerazione a questo discorso: la gente delle mie parti, quando va a mangiare fuori, chiede sempre le stesse cose senza mai aprirsi alle novità. Non credo nemmeno che questa sia una domanda, però mi sembra un comportamento paradossale. Cosa ne pensi?
Le persone sono libere di mangiare quello che vogliono. Detto questo, l’offerta crea la domanda. La prima cosa che chiedo quando mi avvicino a un tavolo col menu in mano è: “volete qualcosa che vi rassicuri o qualcosa che vi sorprenda?”. Il mio lavoro è proporre, idealmente, entrambe le cose.
«Prendere un frutto, metterlo su un piatto, e servirlo come dolce, è impiattare: è il ‘grado zero’ dell’impiattamento (anche il mio pc, come il tuo, lo considera errore, ndr). Scegliere di non fare nulla è, sempre e comunque, fare qualcosa. Anzi». In queste poche frasi riconosco Barthes e Kierkegaard. Quanto la tua formazione letteraria influisce nella e sulla tua cucina? E stando sul pratico, quanto è sottile la linea che divide una presentazione sciatta dalla teoria dell’impiattamento?
Ogni gesto crea un’immagine e quindi un’estetica. Il bello dei segni non verbali è che possono essere capiti e recepiti anche senza essere coscienti di quello che significano: una “presentazione sciatta”, in un certo senso, fa sentire il cliente al riparo da una parte del campo culturale contemporaneo, e ciò facendo crea un altro campo culturale parallelo, fatto di quelli che si vogliono sentire al riparo da quell’altro, e via di seguito. Sarò old school, ma tutto è testo.
L’oste come figura di frontiera, l’oste queer, l’oste dotato di quella che «Carlin Petrini chiama ‘intelligenza affettiva’». Anche a livello umano, come dentro il cibo che si cucina, è questione di equilibrio…
Niente mi ferisce di più che sapere che un cliente non si è sentito a proprio agio al mio tavolo, perché si è sentito escluso da qualcosa. Non mi interessa creare ambienti “esclusivi”, o di tendenza: so perfettamente come si fa, ho vissuto a Parigi 10 anni! Ma non mi interessa.
Nell’ultimo capitolo parli di Stefano, un cuoco che sedeva sempre allo stesso tavolo del bar. In tedesco, lingua che permette la composizione di parole splendide, esiste il termine Stammtisch che sarebbe il tavolo della tribù. Qui dalle mie parti c’è un locale, aperto solo due giorni a settimana, che ha uno Stammtisch con una scritta al di sotto che recita “Da sitzen, die die immer da sitzen”, ovvero “qui siedono quelli che siedono sempre qui”. Trovo che i bar, i ristoranti – soprattutto quelli storici e cristallizzati nel tempo – ti mettano dentro una voglia di raccontare e di raccontarli. Sei d’accordo?
Decisamente. I bar e i ristoranti sono forse l’unico antidoto che ci resta alla solitudine strutturale delle nostre società. Ce ne accorgiamo ancor di più da tre settimane, in cui non ci possiamo più andare.
La cucina del presente e del futuro è una cucina piena di passato, di nostalgia. Potrebbe essere solo una moda?
Il passato che cerca la cucina dei nostri giorni è – fortunatamente – un passato immaginario, perché nessuno di noi sa veramente come si cucinava negli anni sessanta. Non ci sono foto, i ricettari sono inaffidabili (come quasi tutti i ricettari), e la memoria di chi c’era è ancor più inaffidabile. Quindi ci sono due possibilità: o ci ingozziamo di un passato semplificato e finto (e lo stiamo facendo), oppure, come diceva Mark Fisher, cerchiamo di liberare i potenziali inesplorati del passato, cioè i piatti che sarebbero potuti accadere ma che non sono accaduti.
Nel libro citi Mario Soldati: «Se volete trovarvi bene in Italia – spiego ad amici stranieri – dovete scoprirla per conto vostro, affidandovi alla vostra fortuna e al vostro istinto, perché una grande legge dell’Italia è proprio questa: che, da noi, tutto ciò che ha un titolo, un nome, una pubblicità, vale in ogni caso molto meno di tutto ciò che è ignoto, nascosto, individuale». Goethe, nel suo Viaggio in Italia, diceva più o meno lo stesso, dando importanza all’occhio, all’esperienza viva. A proposito di tutto questo discorso, quanto credi che le recensioni, Tripadvisor e strumenti del genere influiscano sul mondo della ristorazione? E poi, reputi corretto che chi non ha conoscenze adatte per esprimere un pensiero si senta in dovere di giudicare?
Quegli strumenti non mi riguardano.
Cinque anni fa intervistai dei miei vecchi compagni di istituto alberghiero, tutti fuggiti all’estero alla ricerca di una ristorazione migliore, sia dal punto di vista dello stipendio che da quello della qualità. Ora, alcuni sono già tornati, altri stanno tornando, pochi sono quelli che rimangono nel luogo di adozione. Come si spiega questo controesodo che possiamo ritrovare anche in molti dei colleghi che descrivi nel libro? Esiste, a tuo parere, un comune denominatore?
A me non risulta che stiano tornando. Almeno, i miei amici e colleghi a Parigi o Berlino se ne guardano bene. Tornare in Italia per fare ristorazione, salvo forse a Milano, è una follia. Stavo benissimo a Parigi, guadagnavo il triplo di quello che guadagno adesso: tornare è stato un sacrificio, ma credo ne valesse la pena, per raccontare una storia che diversamente non sarebbe forse stata raccontata.
Solitamente c’è sempre una dicotomia molto marcata tra cucina e sala. Nel tuo libro, invece, non ho percepito questa sensazione, anzi.
Mi fa molto piacere. In inglese c’è una categoria che include tutte le professionalità del settore dell’accoglienza, hospitality. In italiano non c’è, e tuttavia siamo il paese in cui il rapporto fra sala e cucina è storicamente più fluido. Ed è il modo in cui l’ho sempre fatto io: non vedo la differenza fra grigliare un pezzo di carne o aprire una bottiglia di vino. Una volta si diceva che la terra è di chi la lavora: i banconi e le cucine sono di chi ci sta dietro.
Nel libro senti più volte la necessità di specificare “lo” o “la” chef (anche qui, il correttore automatico mi sottolinea come errore quando scrivo “la chef”). Stiamo arrivando ad una parità di genere in cucina oppure il processo è ancora lungo?
Il processo è ancora lungo ma la nostra generazione può essere determinante. La lingua italiana non ha il genere neutro: organizziamoci. Anche il modo in cui si raccontano le cose ci permette di cambiarle in meglio.
Finiamo col boom della cucina in televisione, che credo abbia dato un’idea completamente distorta di ciò che è il mondo della ristorazione.
C’è roba buona e roba meno buona, è normale. Ma se il pubblico ha voglia di guardare quello, a maggior ragione vale la pena di far passare tramite quei programmi di cucina i contenuti giusti.