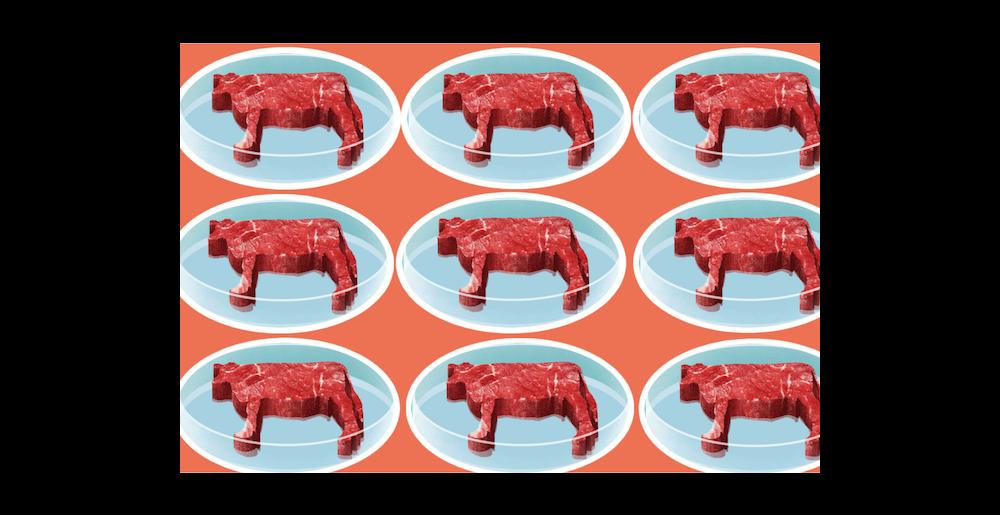Era il 2013 quando Mark Post, professore di fisiologia dell’Università di Maastricht, presentò in conferenza stampa a Londra il suo primo prototipo di hamburger sintetico. All’apertura un po’ goffa della cloche spuntò fuori un dischetto di quella che alla vista poteva sembrare della vera e propria carne trita, col suo colore rosso (un po’ sbiadito a dirla tutta, come se avesse preso aria per un paio di giorni) e con quella che sembrava la classica consistenza della carne macinata. Ma non lo era: l’hamburger mostrato da Post, infatti, era frutto di almeno sette anni di studi e di oltre due anni di lavoro in laboratorio.
La tecnica utilizzata da Post per produrre la sua clean meat – da non confondere con la cosiddetta fake meat, ovvero surrogati totalmente di origine vegetale, in particolar modo composti da soia e da legumi – è la seguente: tramite una sorta di biopsia si prelevano delle cellule staminali dall’animale vivo, dopodiché si fanno crescere in un brodo di coltura fino a che non si forma una quantità sufficiente di tessuto. Giunti a questo punto, le cellule devono essere messe su una impalcatura in grado di consentire la crescita delle stesse e devono poi essere sottoposte a stimoli meccanici per favorire lo sviluppo delle proteine.
Post, a Londra, mentre i critici gastronomici analizzavano la consistenza della carne coltivata e ne apprezzavano la carnosità, puntualizzò che ogni singolo hamburger aveva un costo di produzione di circa 250000€ e tenne anche a precisare che per la messa in vendita della sua carne ci sarebbe voluta ancora una decina d’anni.
Col senno di poi Post non ci andò molto lontano. A dicembre 2020, infatti, su tantissime testate internazionali è rimbalzata la notizia che il governo di Singapore ha autorizzato ufficialmente la vendita di carne sintetica, nello specifico pepite di pollo prodotte dall’azienda californiana Eat Just.
La catena della produzione della carne che va dalle fattorie e, col tempo, arriva al laboratorio, ricorda Il dilemma dell’onnnivoro, libro ormai di culto del giornalista americano Michael Pollan. All’interno dell’opera, uscita nel 2006, Pollan ripercorre tre diverse filiere alimentari – quella industriale, quella biologica e la sua catena personale che lo porta a cucinare una cena con prodotti interamente raccolti o cacciati da lui stesso – col fine di capire come mai siamo arrivati al punto in cui «la più naturale delle attività umane, scegliere cosa mangiare, è diventata un’impresa che richiede un notevole aiuto da parte degli esperti». Il dilemma dell’onnivoro – già indagato anche da Rousseau, Brillat-Savarin e altre figure citate nel testo – cresce ancora di più in una società dell’abbondanza come quella in cui viviamo, dove «decidere cosa è bene mangiare genera inevitabilmente una certa apprensione, soprattutto se certi cibi possono rivelarsi dannosi per la salute o addirittura letali».
Una delle considerazioni che guidano il complesso sistema di problematizzazioni che Pollan si impone lungo la sua narrazione è strettamente legato alla luce solare. La sua idea, semplificando, parte più o meno da questa considerazione: ingeriamo calorie e poi le consumiamo. Il punto è che la fonte primaria delle nostre calorie è passata dall’essere il sole ai combustibili fossili. Nel ripercorrere la storia del mais, Pollan segna come punto cruciale il 1947, quando una fabbrica di munizioni dell’Alabama fu convertita in una ditta produttrice di fertilizzanti di sintesi. Questa possibilità fu resa possibile in seguito all’invenzione del processo Haber-Bosch, tramite il quale l’azoto, fondamentale nei cicli biologici, fu reso disponibile dalla chimica. L’uomo, grazie a tale avvenimento, «ha acquisito la capacità di fissare l’azoto», pertanto «la fertilità del suolo ha cessato di dipendere esclusivamente dall’energia solare ed è entrata nell’orbita dei combustibili fossili». Questa nuova metodologia di fertilizzare i campi si ripercuote poi anche negli allevamenti intensivi, dove ad esempio i bovini, animali erbivori, vengono nutriti con mangimi a base di mais. Scrive sempre Pollan:
Ecco cosa è riuscito a combinare il mais: ha industrializzato quel miracolo della natura che è un ruminante, trasformando un perfetto organismo alimentato a luce solare, erba e pascoli in un’ennesima macchina che consuma combustibile fossile, ma che in più prova dolore. L’ultima cosa di cui avevamo bisogno.
E poi, al termine di una sua visita ad un feedlot, Pollan conclude:
Siamo quello che mangiamo: è difficile non essere d’accordo. Eppure manca qualcosa: come insegna la visita a un allevamento industriale, siamo anche quel che mangia quel che mangiamo noi. E oggi siamo, o siamo diventati, non solo carne, ma anche mais n.2 e petrolio.
A margine di questo, dove si colloca la carne sintetica? Mark Post, nella sua intervista, sottolineava come i suoi maggiori interessi legati allo sviluppo della carne sintetica fossero il dare una risposta alla crescente domanda di carne (specialmente da parte dei Paesi BRIC), diminuire le emissioni di gas metano prodotte dal bestiame e infine di affrontare i problemi legati al benessere degli animali degli allevamenti intensivi.
Ancora una volta – dal lato della società occidentale – l’interrogativo che ci si pone è legato a doppio filo con la domanda cardine di Pollan: cosa è bene mangiare?
La risposta a questa domanda non è univoca e analizzare i pro e i contro di ogni dieta possibile per arrivare ad una conclusione sarebbe utopistico. Tuttavia è innegabile che ogni singola persona debba compiere una scelta, che ogni singola persona si trovi di fronte al suo dilemma. È per questo che da Alain Ducasse a Massimo Montanari si parla di mangiare come atto civico e politico, come un comportamento in grado di cambiare le sorti di ambiente, di animali e di esseri umani. La clean meat si inserisce perfettamente nella discussione: può combattere effettivamente la domanda di carne? Può rivelarsi utile nel diminuire l’impatto ambientale degli allevamenti intensivi? Può essere presa in considerazione da chi segue una dieta vegetariana o vegana?
Alla fine della presentazione di Post, una giornalista gli domanda come poter passare oltre lo yuck factor, ovvero la sensazione di sgradevolezza legata al fatto che la carne nasca in laboratorio. Post risponde che il problema sta nel come il prodotto viene commercializzato. Aggiungo io: commercializzarlo verso quale target? I mangiatori di carne saranno disposti ad accogliere la novità? Si fideranno? O ancora: il costo della carne in vitro diventerà mai abbordabile per tutte le tasche? Ci saranno conseguenze a livello ambientale? E per chi invece segue una dieta vegetariana o vegana: come approcciarsi alla novità? Qui il filo si dipana lungo le varie motivazioni che spingono le persone verso questi stili di vita. Se il problema fosse la salute degli animali allora non dovrebbero esserci problemi, dato che la procedura sembrerebbe essere cruelty-free. Tuttavia per chi si dichiara antispecista potrebbe sorgere il problema della violenza sull’animale per il prelievo delle cellule muscolari.
Lungo questa scia si potrebbe continuare all’infinito e, come fatto da Dario De Marco in un articolo apparso su Singola, si potrebbe andare addirittura a scomodare, potenzialmente, la possibilità di ricreare carne anche di animali che solitamente non si mangiano o, perché no, persino carne umana.
Ma non è questo il punto. Ancora una volta è tutto un discorso di direzione e ricezione del messaggio: siamo disposti ad accettare le ultime novità della tecnologia alimentare?
F.T Marinetti, nel Manifesto della cucina futurista pubblicato nel 1931 sul mensile La cucina italiana. Giornale di gastronomia per le famiglie e per i buongustai, si auspicava un intervento della chimica all’interno del mondo della gastronomia: «invitiamo la chimica al dovere di dare presto al corpo le calorie necessarie mediante equivalenti nutritivi gratuiti di Stato, in polvere o pillole, composti albuminoidei, grassi sintetici e vitamine» in modo tale da abbassare così il costo della vita, dei salari e di conseguenza diminuire anche l’orario lavorativo. Quest’ultimo aspetto consentirà quindi di «perfezionare e nobilitare le altre ore col pensiero le arti e la pregustazione di pasti perfetti».
I pasti perfetti a cui allude Marinetti sono delle vere e proprie performance multisensoriali, in cui forchetta e coltello vengono aboliti per fornire «un piacere tattile prelabiale», dove profumi scelti vengono spruzzati nell’aria per conciliare la degustazione, dove la musica è limitata agli intervalli per non distrarre «la sensibilità della lingua e del palato». Tuttavia rimangono comunque pasti composti da alimenti “naturali”, in cui la chimica si inserisce solo nel linguaggio tradizionale della cucina.
Persino Marinetti, dunque, favorevole ad un’alimentazione sintetica, avrebbe qualche riserva: sintetico sì – sintetico anche – ma non solo. Sintetico per necessità, per poi dare spazio anche ad altro, a qualcosa già perfetto di natura. Una natura che però l’uomo, da sempre, cerca di piegare alla propria volontà: lo ha fatto utilizzando il fuoco (“inventando” così la cucina), imparando le tecniche di conservazione, prendendo confidenza con i processi di fermentazione. E si potrebbe continuare.
Resta comunque il fatto che, come sostiene Massimo Montanari, il gusto sia non solo un prodotto culturale («il cibo non è buono o cattivo in assoluto: qualcuno ci ha insegnato a riconoscerlo come tale»), ma anche un prodotto sociale. Nel Medioevo le spezie erano costose e appannaggio delle classi più abbienti che le utilizzavano per arricchire i loro piatti; nel tempo poi il loro prezzo è calato e i nobili sono andati in cerca di altri modi in cui spendere il proprio denaro (ad esempio il burro e i prodotti di pasticceria). Montanari sostiene che il criterio con cui si muovono le persone facoltose sia appunto l’antieconomicità. Non deve sorprendere allora che Bill Gates stia investendo ingenti somme di denaro nello sviluppo della carne sintetica e che – come si può leggere in un’intervista rilasciata alla MIT Technology Review – stia provando a convincere i Paesi ricchi a passare a questo tipo di alimento:
Non credo che gli 80 Paesi più poveri mangeranno carne sintetica. Penso che tutti i Paesi ricchi dovrebbero passare al manzo sintetico al 100%. Ci si abitua alla differenza di gusto e la pretesa è che il sapore verrà reso ancora migliore nel tempo.
Per adesso, tuttavia, il costo della produzione di un singolo nugget di pollo di Eat Just dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 dollari rendendolo di fatto ancora non alla portata di tutte le tasche. Non resta che aspettare il proseguo della storia per capire come evolverà la produzione, la sensibilità delle persone, ma soprattutto il costo del prodotto. Perché, come sostiene l’antropologo Marvin Harris, le scelte alimentari delle classi subalterne sono compiute per convenienza: buono significa pratico e economico. Solo dopo buono da mangiare diventa buono da pensare.